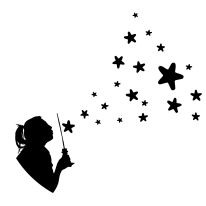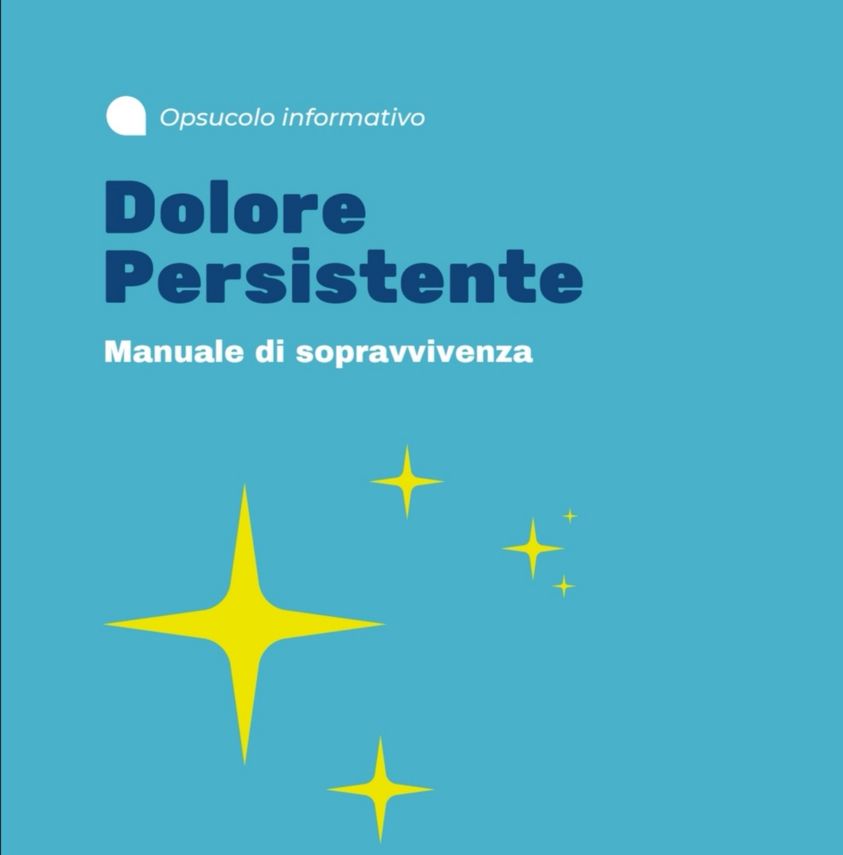Adoro Sex and the City. In realtà non l’ho voluto mai guardare per anni, perché mi sembrava rozzo e volgare, ma una volta che l’ho fatto, me ne sono innamorata. E, alla fine, quando è la serie è terminata, con Carrie che camminava fresca, felice e fiera, rimbalzando sui suoi tacchi e su “You’ve Got the Love” di Florence + the Machine per i marciapiedi di NY, avevo, e ho tutt’ora, la sensazione che fosse finita un’era.
Sex and the City ha segnato una piccola rivoluzione, forse avrà anche portato un’istanza femminista all’acqua di rose, ma grazie a Sex and the City le donne ora hanno una lingua con cui parlare delle loro esperienze sessuali, delle loro amicizie, delle loro storie e idiosincrasie.
Certo, i tentativi di emancipazione post femminista restano sempre confinati in un mondo tutto sommato “femminile” ed eterosessuale, ma nemmeno troppo. Insomma, lo adoro. Punto. È stato un fenomeno socioculturale da cui non si può prescindere.
Eppure c’è una cosa che non perdono a Sex and the City. Stagione 4, episodio 2. Ve lo ricordate quel certo momento in cui Charlotte comunica alle sue amiche che le è stata diagnosticata la vulvodinia e che la sua vagina è “depressa?” Depressa. La vagina depressa. Una spiegazione più ottusa credo di non averla mai sentita. Sono andata ad ascoltare anche l’audio originale, per essere sicura che non ci fossero state “licenze poetiche” nella traduzione. No. La vagina è depressa, per gli italiani e gli anglofoni.
Bene. La mia esperienza personale con il dolore cronico vulvare, perché sì, mi è toccato anche quello, è piuttosto descrittiva della situazione. Innanzitutto, parlando in modo così deliberato delle mie pudenda, sto in realtà infrangendo il primo tabù perché sì, non se ne parla, non se ne deve parlare. Quindi mia madre, da brava femminista, credo abbia combinato qualche danno, facendomi essere così spudorata rispetto alla questione.
Viviamo in una società un tantino fallocentrica. Da una rapida ricerca, noto che il “mercato” rispetto alla disfunzione erettile (l’unica condizione medica maschile con cui mi è sembrato ragionevole creare una comparazione) è saturo, con nuovi studi che vengono pubblicati continuamente: le referenze su PubMed sono 24.289, che crollano a 789 sul tema “vulvodinia”. Sono d’accordo se obiettate che, fra le presentazioni che indico, ci sono sicuramente anche articoli di bassa qualità, ma converrete che, anche volendo fare una scrematura e tenendo solo quelli di qualità elevata, proporzionalmente non c’è storia.
La vagina o non interessa (scientificamente parlando) o fa paura. E questo complica le cose. Strano, considerando che il 16% della popolazione femminile USA incontra la vulvodinia nella propria vita. Se estendiamo la statistica al resto del mondo, il problema è degno di nota.
Uno studio americano del 2001 dal titolo “The girl who cried pain: a bias against women in the treatment of pain” (La ragazza che urlava per il dolore: il pregiudizio contro le donne nel trattamento del dolore) ha dimostrato che nonostante le donne vivano il dolore più frequentemente degli uomini nella loro vita quotidiana, gli uomini ricevono un trattamento migliore per i loro sintomi dolorosi. Una malattia cronica, di qualsiasi tipo, porta già uno stigma, ma questo è peggiorato se la condizione è invisibile, spiega il sito della UK Vulval Pain Society. E, guarda caso, la vulvodinia, come unica manifestazione, ha il dolore.
Immaginate quindi una malattia cronica dolorosa e senza una apparente causa organica, applicata ad una donna, alla parte anatomica più rappresentativa della femminilità, e avrete creato la tempesta perfetta.
Io la vulvodinia la conosco. Mi ha distrutto l’esistenza, fatto perdere lavori, fatto scoprire le benziodiazepine e l’autolesionismo. E, francamente, non ci ho mai capito niente, tranne che i sintomi, che avevo imparato a controllare con la respirazione e il biofeedback, sono tra quelli scomparsi da quando ho iniziato il mio percorso di cura.
.
Vagina depressa, vagina depressa… cara la mia Charlotte, ti manca un pezzetto di definizione. Non solo la nostra amica V. è depressa perché non può svolgere le sue funzioni sessuali, ma è anche profondamente addolorata. Dal punto di vista emotivo e fisico. Dolore urente, spesso costante. Questo è quello che riferiscono le pazienti che hanno avuto la sfortuna di conoscere la vulvodinia.
Nel 2015 il Consensus Terminology and Classification of Persistent Vulvar Pain and Vulvodynia ha riportato la seguente definizione: dolore localizzato (clitorideo o sulle piccole labbra) o generalizzato, provocato o spontaneo, ad origine primaria o secondaria (candidosi recidivanti), costante o intermittente (cicli mestruali).
La vulvodinia impatta più o meno con il normale decorso della vita quotidiana delle pazienti e questo dipende dalle sue caratteristiche e da quanto possa essere “soggettivamente invalidante”. In fondo, il dolore è una proiezione del nostro sistema nervoso centrale e sta al singolo soggetto determinane l’intensità o meno.
Di grazia, il dolore resta dolore e una fiamma ossidrica costantemente presente sul nostro tesoro più prezioso influisce, eccome se lo fa. Influisce sulla percezione del nostro corpo, sul come conduciamo la nostra vita e sul come, inevitabilmente, viviamo la nostra sfera sessuale.
“Dai, in fondo è solo un po’ di infiammazione metti un po’ di crema, di certo ti sarai irritata con quei jeans super attillati… Usiamo un po’ di lubrificante amore, sei solo un po’ stanca e stressata”. Aha, sì, le favole.
La vulvodinia è un dolore neuropatico. No nessuna è pazza, nessuna è isterica. Il sistema nervoso centrale si modifica, cambia, si sensibilizza, diventa costantemente permaloso, ecco.
Il danno può essere localizzato in qualsiasi punto del sistema nervoso: nel sistema periferico, nel sistema spinale o sopraspinale, nel cervello.
La spiegazione è “semplice”: i meccanismi nervosi che modulano la sensazione del dolore sono confusi e possono inviare l’informazione nocicezione al cervello in maniera amplificata; allo stesso modo il cervello può urlare “al lupo” senza giusta causa perché qualcosa sta funzionando troppo e troppo spesso. Sotto il profilo clinico, il dolore neuropatico è caratterizzato da due processi sensoriali anomali, detti iperalgesia e allodinia. Nel primo caso intendiamo una risposta amplificata ad uno stimolo doloroso di per sé normale; nel secondo intendiamo un viraggio della percezione dello stimolo da tattile a “doloroso urente”. Non è un miraggio, in fondo.
Fortunatamente questi meccanismi cominciano ad essere masticati dai più fino ad arrivare a considerare i fattori psicosessuali una conseguenza diretta della vulvodinia più che la causa.
L’interazione tra fattori biologici, predisponenti, precipitanti e di mantenimento, che concorrono al danno organico e neurogeno della vulva, possono interagire con fattori di tipo psicogeno, che hanno sempre, peraltro, un correlato neurochimico. Dolore neuropatico é sostanzialmente una diagnosi clinica che ha bisogno di essere avvalorata da test riproducibili o da esami diagnostici (per farla breve: si deve “vedere” da qulche parte, nella fattispecie in un esame diagnostico appunto).
Capita spesso in studio che arrivino delle pazienti con una sorta di Treccani personale. Il famoso dottor shopping, ma nessuno é riuscito a trovare qualcosa che potesse essere origine del dolore: faldoni sul faldoni di esami medici, tutti negativi. La paziente è disperata, soffre, ma “non ha niente”, secondo i test. Capita, molto spesso. Fino a qualche tempo fa si restava a bocca aperta, spiazzati e frustrati. Fortuna che nel 2016 quei gran geni della IASP – International Association for the Study of Pain hanno trovato l’esigenza di introdurre un terzo punto chiarificatore per coloro che non hanno “niente” (niente che si trovi o che si veda in un esame di laboratorio). Il dolore nociplastico. Cito testualmente: dolore che emerge da un’alterata nocicezione senza lesione o minaccia di un tessuto che possa essere causa dell’attivazione dei nocicettori periferici o evidente lesione del sistema somatosensitivo che possa essere causa di dolore. In pratica, esistono persone che sentono “spontaneamente”. In questo caso, sopratutto in questo caso, la componente psicosociale gioca un ruolo fondamentale come ulteriore attivatore del processo algogeno attivando il circuito del cane che si morde la coda.
Rosemary Basano ha concettualizzato un modello che spiega, in maniera circolare, il funzionamento sessuale di una donna. Il contesto e lo stato mentale sono gli elementi più importanti del ciclo sessuale femminile. Gli anelli d’incastro di questa catena sono inoltre gli stimoli sessuali e infine la soddisfazione emotiva e fisica (orgasmo). Lo stato mentale di una donna con dolore vulvare persistente o presente durante un rapporto- dispareunia- non sarà di certo predisponente. Mettiamo caso che ci troviamo di fronte ad una donna con una forza mentale sopraffine, una di quelle che non si lascia scoraggiare: il dolore coitale dovuto alla dispareunia interferisce comunque con i diversi aspetti della funzione sessuale. Direttamente inibisce la lubrificazione vaginale, provocando difficoltà di eccitazione con secchezza vaginale: difficoltà di orgasmo, frustrazione, insoddisfazione, perdita secondaria del desiderio sessuale e dell’eccitazione mentale con conseguente evitamento dei rapporti.
Quando il sintomo si manifesta da subito come dolore vulvare, si associa innanzitutto a un’infiammazione della muscosa. Questa determina poi la contrazione difensiva dei muscoli elevatori dell’ano (componenti principali del pavimento pelvico) e, infine, la proliferazione delle fibre del dolore. Quando invece, su muscosa integra, il sintomo di partenza è il dolore al rapporto, la prima conseguenza e la contrazione difensiva dei muscoli elevatori dell’ano, cui seguono il blocco della lubrificazione, microabrasioni da penetrazione e proliferazione delle fibre nervose del dolore con vulvodinia infine neuropatica. (Graziottin et al. 2011).
Dottore, cosa posso fare?
Natalie O.Rosen nella sua review ha cercato di indagare, in base alla letteratura esistente, quale potesse essere il trattamento migliore per pazienti affette da vulvodinia. La sua conclusione, che tra le altre cose supporta anche il Fourth International Consultation on Sexual Medicine, sottolinea che le migliori opzioni di trattamento sono: interventi psicologici (no, non perchè qualcuno sia matto, ma per imparare a gestire il dolore nel quotidiano), fisioterapia del pavimento pelvico, vestibolectomia (per la vestibolodinia provocata). I trattamenti farmacologici posso portare dei benefici e includono agenti antinocicettivi, agenti anti-infiammatori, neuromodulatori, miorilassanti.
Come detto in precedenza esiste un link evidente tra vulvodinia e disfunzioni dei muscoli del pavimento pelvico, traducibili in ipertono, mancanza di forza e controllo. L’obiettivo della riabilitazione del pavimento pelvico è quello di restituire la funzionalità a muscoli e tessuti, abbassare la tensione neurale, migliorare la funzionalità sessuale.
La terapia manuale del pavimento pelvico include una grande varietà di tecniche come stretching, massaggio e e trattamento dei trigger points agendo direttamente sulla parte trattata e neuromodulando l’informazione che dalla periferia arriva al sistema nervoso centratale. Andiamo a trattare il sistema nervoso centrale, indirettamente.
Studi retrospettivi hanno registrato significativi miglioramenti nel dolore riferito, nella dispareunia nelle funzioni sessuali dopo l’applicazione della TENS: corrente che è in grado di chiudere i “cancelli” a livello midollare che inviano l’informazione alterata del dolore al sistema nervoso centrale.
Riabilitazione sì, farmaci forse, esercizio terapeutico? L’esercizio terapeutico a basso carico, adattato al singolo, personalizzato in base alla richiesta d’aiuto ha fondamentalmente lo stesso effetto dei farmaci neuromodulatori. L’esercizio fa produrre roba buona al nostro organismo, stimolandolo, tenendolo vivo. Tra le altre cose non dimentichiamo che le pazienti che soffrono di vulvodinia possono essere soggette ad fibromialgia e altre patologia che hanno a che fare con il dolore cronico.
Riabilitazione sì, farmaci forse, esercizio terapeutico si e tanta consapevolezza.
.
Purtroppo le informazioni scientifiche, anche fra i medici, faticano a diffondersi e la vita delle pazienti affette da vulvodinia è spesso un’odissea da uno specialista all’altro, da una terapia all’altra senza alcun risultato. Se, dopo la cura, come accade, poiché non specifica per il problema, i sintomi rimangono, la paziente si sente dire che non ha nulla e, spesso, di rivolgersi allo psicologo. Quasi sempre la diagnosi, quindi, diventa quella di malattia psicosomatica. Purtroppo si tratta di una situazione piuttosto diffusa e capita spesso che le pazienti si ritrovino senza una cura e con l’etichetta di “malate immaginarie”. Alcuni studi sottolineano tuttavia come il profilo psichiatrico delle donne con vulvodinia non sia diverso da quello di donne con altri disturbi vulvari.
Così ritorniamo ad uno dei nostri soliti discorsi. Deve esserci una maggiore consapevolezza della condizione sia tra gli operatori sanitari che tra il pubblico in generale. I medici dovrebbero essere meglio addestrati a riconoscere e diagnosticare la vulvodinia per sapere quali trattamenti offrire, ma anche come spiegare alle pazienti la loro condizione.
Forse l’unica esattezza che Sex and the City offre è quando le amiche di Charlotte le rispondono “Vulvo-che?” mentre rivela la sua diagnosi. Questa reazione è fin troppo diffusa tra la gente comune e persino tra i professionisti della salute. Come sempre, la ricerca fortunatamente c’è, c’è però il solito scollamento tra la ricerca e la pratica.
Forse Sex and the City non ha proprio fallito miseramente. L’ha fatto nel banalizzare la natura seria e complicata di questa condizione, ma ha avuto il pregio, almeno, di far parlare del problema, ancora, a distanza di quasi vent’anni (sigh!) da quella puntata.
Questo articolo non è solo farina del mio sacco. Per metà è stato scritto da Carla Sforza, che mi ha aiutato a dare senso ad un grande buco nero della mia esistenza. Lei è una delle “belle scoperte” che “Le Stelline” ha portato con sé e per cui non sarò mai abbastanza grata. Carla è fisioterapista libera professionista, terapista manuale, specializzata in riabilitazione del pavimento pelvico nell’incontinenza urinaria femminile e nel dolore pelvico cronico. La trovate su Facebook come Fisioelle.
Fonti:
“The girl who cried pain: a bias against women in the treatment of pain” by Hoffmann DE, Tarzian AJ. on The Journal of Law, Medicine and Ethics 2001 Spring;29(1):13-27 PubMed# 11521267
2015 ISSVD, ISSWSH and IPPS Consensus Terminology and Classification of Persistent Vulvar Pain and Vulvodynia by Bornstein J1, Goldstein AT, Stockdale CK, Bergeron S, Pukall C, Zolnoun D, Coady D on Obstet Gynecol. 2016 Apr;127(4):745-5 PubMed #27008217
Psychological characteristics and outcome of patients attending a clinic for vulval disease Fenella Wojnarowska Richard Mayou, Sue Simkin, Alex Day on Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, July 2006
Graziottin A, Murina F. Vulvodinia strategie di diagnosi e cura. Springer- Verlag Italia 2011
Rosen NO, Dawson SJ, Brooks M, Kellogg-Spadt S. Treatment of Vulvodynia: Pharmacological and Non-Pharmacological Approaches. Drugs. 2019 Apr;79(5):483-493. doi: 10.1007/s40265-019-01085-1. PubMed PMID: 30847806.
www.vulvalpainsociety.org
www.nva.org