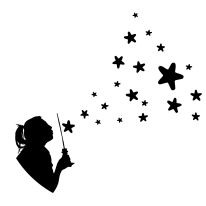“Il farmaco toglie il sintomo, ma non aiuta ad affrontare quello che ha portato a stare male. La psicoterapia toglie il sintomo e permette di affrontare le difficoltà che hanno portato a sviluppare il sintomo”.
Mh.
Calmi. Non perdiamo la testa. Come assunto di base può anche funzionare.
La psicoterapia ha portato un’istanza di rinnovamento rispetto ad una visione tendenzialmente meccanicistica, in qualche modo funzionalistica dell’essere umano. Non possiamo però considerarla la panacea per tutti i mali o, almeno, non nel caso del dolore persistente. Se la psicoterapia ha cambiato la visione dell’essere umano, che quindi non è una macchina, sembra essersi inceppata su una delle sue premesse fondamentali. Il dolore è considerato come espressione della dissociazione da un trauma emotivo: sembra essere un assioma. Ma lo è realmente? Il dolore persistente lo sfida. Lo sfida scientificamente.
Per quanto esistano dei fattori psicosociali predittivi (traumi emotivi, condizioni socio-familiari avverse…), questi non sono una condizione sufficiente per lo sviluppo di dolore persistente (non tutti quelli che hanno dolore persistente, hanno vissuto tali condizioni): il dolore ha necessariamente una base biologica dimostrabile e verificabile (incluso il dolore nociplastico, per cui sono apprezzabili cambiamenti corticali strutturali e funzionali –il famoso dolore “che non si vede da nessuna parte”).
Se il dolore è un problema su base organica, non è umano pensare di curarlo con estenuanti sedute di psicoterapia alla ricerca del trauma perduto, che magari non c’è (e spesso non c’è). Piuttosto sarebbe utile rinunciare alla premessa dolore=dissociazione e smettere di considerare le persone con dolore persistente come persone malate: hanno una malattia, non sono la loro malattia, ammesso che il dolore persistente sia una malattia, piuttosto che una condizione (psico)fisica.
Scientificamente, le neuroscienze mettono in discussione le premesse della psicoterapia. La persona con dolore persistente non è una persona malata, è una persona che vive una condizione (psico)fisica, ma non è da identificare con il suo problema, con la sua difficoltà, con la sua condizione dolorosa, è una persona che ha bisogno di essere curata, ma non in termini medici: ha bisogno di essere accolta, tout court. La cura “medicalmente intesa” ha come obiettivo quello di portare alla condizione precedente a quella della malattia: spesso non è possibile. Compito della psicoterapia, accolti tutti questi assunti, dovrebbe essere aprirsi genuinamente a queste nuove istanze.
La Scienza del Dolore, è una scienza nuova, che guarda con occhi nuovi un problema antico. Non è possibile pensare di trovare soluzioni innovative rimanendo ancorati a vecchi pregiudizi. La psicoterapia, che agli albori del Novecento si è fatta portatrice di una rivoluzione, ha la possibilità di rinnovarsi giocando un ruolo nuovo e importantissimo, dando alle persone con dolore persistente sguardi diversi e strumenti alternativi per rapportarsi con il proprio vissuto in modo costruttivo ed efficace, scollandosi dalla vecchia visione di cui abbiamo parlato che, in questo caso, dimostra la sua inefficacia.
Nel caso del dolore persistente, l’intervento sul sintomo non è utile, perché si agisce con l’idea che sia la manifestazione di qualcosa, del famoso “trauma represso”, mentre il dolore non è il sintomo, ma la manifestazione: se si entra in quest’ottica si può cercare di capire come influisca sulla vita di chi ci convive costantemente e quindi diventa possibile lavorare a diversi livelli sul dolore e sulle sue manifestazioni, scardinando l’idea che ci sia qualcosa da curare, per cercare piuttosto di capire come sia possibile aumentare l’autoefficacia e vivere bene con il dolore.
.
(Abbiamo scelto di parlare di psicoterapia, non di psicologia, perché questa interviene direttamente sui costrutti epistemologici della personalità e sul funzionamento delle persone stesse).
.
Articolo scritto con Andrea Ghirelli, amico fidato, educatore, mediatore familiare, counselor sistemico relazionale.
Fonti:
Bardolino Chiaretto Bentegodi, 2018