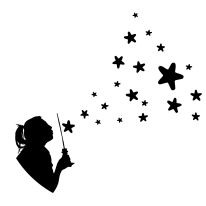Kinesiofobia State of Mind.
Una volta sì. Fobia. Paura del movimento. Paura cronica del movimento. L’ho sempre avuta. Da che ne abbia memoria.
La kinesiofobia è definita come timore eccessivo, irrazionale e debilitante del movimento fisico e dell’attività, derivante da una sensazione di vulnerabilità dovuta ad una lesione dolorosa o a ripetuti infortuni. Ecco. Ho sempre avuto difficoltà motorie (le suore all’asilo non hanno aiutato), che non hanno fatto altro che peggiorare a scuola, dove delle mie fatiche non importava niente a nessuno, anzi: mi ritrovavo travolta da un flusso di ragazzini, le cui competenze motorie erano sicuramente superiori alle mie e a me veniva chiesto di adeguarmi al loro standard, senza averne i mezzi, con risultati catastrofici. Quindi, per me, muovermi e farmi male, era la norma. Io ho cominciato ad avere il terrore delle lezioni di educazione fisica, durante le quali, alle medie, ho rimediato il colpo di frusta che mi ha causato la lesione che mi provoca la nevralgia occipitale, ho rotto un paio di tendini flessori delle dita delle mani e rimediato altre varie figure di 💩 che non sto a raccontare (senza contare la caduta apocalittica che ha aperto la strada al dolore persistente, ma quella è stata accidentale).
Credo che ci sia poco da stupirsi che sia diventata kinesiofobica. In qualche modo, il mio corpo è sempre stato un traditore. È stato normale, per me, scegliere il cervello. Era sicuramente più affidabile.
Ovviamente, negli anni, la mia kinesiofobia, si è nutrita e fatta forte dei “non ti muovere”, che i vari professionisti della salute mi hanno offerto. Ero felice che mi venisse detto di non muovermi. Il fatto è che la kinesiofobia è correlata al dolore cronico. Comprendere questo rapporto può essere difficile, ma è importante per affrontare le “disfunzioni” che possono “causare il ciclo del dolore”. Per riassumere, la convinzione che qualcosa non vada nel nostro corpo, e la convinzione che evitare l’esercizio impedirà un aumento del dolore, conducono ad un circolo vizioso che comporta un evitamento del movimento o di qualsiasi attività che potrebbe (potrebbe, in teoria, secondo noi) causare dolore o infortuni. Nel corso del tempo, l’inattività che deriva da questa paura, porta a conseguenze psicofisiche quali atrofia muscolare, perdita di mobilità e una risposta alterata a stimoli dolorosi e cambiamenti comportamentali, che possono contribuire a perpetuare il dolore. Insomma, un casino: ci intrappoliamo (inconsapevolmente) ancora meglio nel problema.
Immersa nella mia kinesiofobia, quando Luca si è presentato dicendo che mi dovevo muovere per gestire il dolore, ho pensato che fosse pazzo (sorry). Perché avrebbe fatto male, perché non ero capace. E non è andata così. Quello che è successo, è che nel mio percorso ho avuto vicino persone che mi hanno accolto. Hanno ascoltato le mie paure e, un kg dopo l’altro, mi hanno aiutato a farcela.
Quindi, quando mi specchio, con un bilanciere sulle spalle, e vedo tutta l’intelligenza del mio corpo, che aveva solo bisogno dei suoi tempi, di non essere travolto dal flusso “degli altri”, non mi sento semplicemente liberata dal dolore, ma anche dalla paura e dall’insicurezza. E io credo fermamente che il briciolo di autostima che sono riuscita a recuperare, sia passato e passi attraverso lo strumento che mi sentivo meno congeniale: il mio corpo.
Il mio corpo, che guardo sempre più stupita.
Fonti:
Butler DS, Moseley GL. Explain pain. Adelaide: Noigroup Publications; 2015
Crombez G, Vlaeyen JW, Heuts PH, Lysens R. Pain-related fear is more disabling than pain itself: evidence on the role of pain-related fear in chronic back pain disability. Pain 1999;80(1):329–339. doi:10.1016/s0304-3959(98)00229-2.
Lethem J, Slade P, Troup J, Bentley G. Outline of a fear-avoidance model of exaggerated pain perception—I. Behaviour Research and Therapy 1983;21(4):401–408. doi:10.1016/0005-7967(83)90009-8.
Neblett R, Hartzell M, Mayer T, Bradford E, Gatchel R. Establishing clinically meaningful severity levels for the Tampa Scale for Kinesiophobia (TSK-13). Eur J Pain European Journal of Pain 2015;20(5):1–10. doi:10.1002/ejp.795.