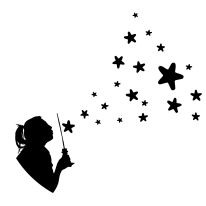Premetto, a mia discolpa, che io amo follemente mia madre. È una donna brillante, un crossing fra Alice nel Paese delle Meraviglie e Piperita Patty. Mia madre è un’artista. Il che significa che ha un gusto raffinatissimo quando si tratta di composizioni di fiori e pittura ad acquarello o di arredamento, ma tutto ciò che non è arte figurativa esula dal suo interesse: il guardaroba, ad esempio. Finché si tratta del suo, non ci sono particolari problemi, per quanto mi riguarda. Ma quando si tratta del mio beh, è stato difficile avere dodici anni e la mise di una militante della controcultura. Quando le mie compagne si nascondevano in bomber della Energie, jeans a zampa e Kikers, io ero condannata a vestiti da intellettuale in erba. Mi prendevano in giro per la mia pelle bianca come il latte, mi chiamavano “la smorta”. No, io non mi abbronzo. Mai. Non è un vezzo. Sono fatta così. Si chiama fototipo 1. Se a questo aggiungiamo il guardaroba, si capisce come la mia voglia di sparire aumentasse, ma diventasse sempre più un desiderio irrealizzabile. Avevo in me il gene dell’essere controcorrente, ma a dodici anni non sapevo cosa farci. Era sabato. Credo fosse primavera. All’uscita da scuola hanno cominciato a prendermi in giro per il colore della pelle. Il maglione oversize non mi aiutava ad avere coraggio. Avevo dei fuseaux neri. Ballerine nere. Non so cosa sia successo di preciso. So che il capo-bullo mi si è parato davanti sfottendomi, poi sono caduta. Lo zaino, pieno di libri, con il suo peso esorbitante, mi ha trascinato all’indietro, e sono rimasta lì, così, per terra, in mezzo alla strada, per un tempo che non so definire, presumo svenuta. Non so da cosa derivi precisamente la frase “vedere le stelle”, che si usa per descrivere l’essere colpiti da un dolore forte e improvviso: fatto sta che io ho visto le stelle anzi, le stelline (eccole qui!). E non si è trattato di uno sfarfallio luminoso davanti agli occhi: ci ho fatto proprio una passeggiata in mezzo, in un tunnel blu notte. E da quel giorno è cominciata la mia lunghissima e complicatissima love story con il dolore cronico. Perché la chiamo love story? Perché il nostro rapporto è stato lungo una vita, la mia, ed è stato difficile, fatto di lunghissimi momenti di reciproca incomprensione, poi in qualche modo è sbocciato, quando io ho trovato il modo per parlare il suo linguaggio: può sembrare delirante, ma non lo è troppo. Lo capirete leggendo. In fondo, non posso dire di odiare la mia vita passata: è stata la mia vita.
Quando mi sono risvegliata, dopo la mia passeggiata astrale (è il caso di dirlo), non c’era più nessuno intorno a me: ero sola, sdraiata in mezzo alla strada e stavo soffocando. Ricordo di essermi sollevata da terra sfilando le braccia dalle cinghie dello zaino, abbandonandolo lì, e di aver camminato rantolando fin tra le braccia di una perfetta sconosciuta che, in qualche modo, massaggiandomi la schiena e abbracciandomi, è riuscita a riportarmi tra i vivi. Non mi sentivo vittima di un atto di bullismo, nel ’92 non ne avevo neppure sentito parlare, ma solo una perfetta idiota: una semplice, ulteriore, vivente conferma della mia goffaggine.
Ecco, a me il dolore cronico tocca da quella epica caduta, della quale, essenzialmente, non è importato un tubo a nessuno. Ero caduta. Tutti cadono. Giocavo con le Barbie e avevo mal di schiena atroci, ma mi dicevano fossero i dolori della crescita. Non mi risultava che nessuno dei miei compagni di classe soffrisse così, per di più in una zona colpita da una botta pazzesca, ma prendevo la spiegazione per buona. Insomma, a me risultava che fosse mia nonna ad avere mal di schiena e io non avevo certo l’età di mia nonna, ma mi facevo andare bene l’interpretazione.