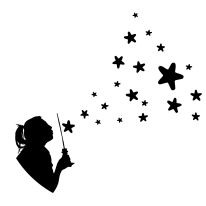Posso sembrare una persona fredda, solitaria, indifferente e priva di sentimenti. Non è così: mi sono dovuta costruire una corazza. Perché sopravvivere al dolore fisico è stato complicato. Così complicato, che a volte non so più dove sono andata a finire.
È stato ancora più complicato sopravvivere al senso di inadeguatezza che mi causava non riuscire a guarire, nonostante tutto il mio impegno.
Fino a ventidue anni circa, non credo di essere stata pienamente consapevole del dolore. C’era, ma non era spaventoso. Ha cominciato ad esserlo dall’estate del 2003, per la concomitanza di una serie di fattori, che adesso riesco ad individuare bene (psicologici, sociali, ambientali, biologici), ma che in quel momento mi sfuggivano completamente.
In quell’estate il dolore, ed una serie di sintomi assurdi, hanno cominciato a mangiarsi tutto. Non sto parlando più solo del dolore muscoloscheletrico e dell’allodinia, ma di rigidità, disturbi del sonno, mal di testa ostinati, acufeni, colon irritabile, alterazioni nella percezione della temperatura corporea, tachicardia, sintomi allergici, vertigini, testa confusa. Mi sentivo una mosca impazzita in un bicchiere capovolto. A quel punto io, già cliente fedele di innumerevoli fisioterapisti, ho cominciato i miei tour dai medici, che immancabilmente si risolvevano in gite dagli strizzacervelli o in cure fallimentari e danni iatrogeni conseguenti.
Il mio dolore e i miei sintomi “correlati” non se ne andavano come previsto, non come mi aspettavo io e nemmeno come si aspettavano i medici, i fisioterapisti, gli osteopati, i chiropratici e gli strizzacervelli.
Così, ad un certo punto, il problema sono diventata io. Il problema non erano il dolore, o i miei sintomi, o la situazione tremenda in cui mi trovavo, o i trattamenti che non funzionavano. Non era chi mi trattava che aveva conoscenze insufficienti sui meccanismi del dolore persistente. No. Il problema ero io. E mi veniva detto in faccia. Come se fossi ostile alla guarigione.
Come esseri umani, in genere, ci piace molto pensare di essere preparati ed empatici, ma mi chiedo se pensiamo mai realmente al potere delle parole. Perché le parole costruiscono mondi. E quelle che mi sono sentita dire dai professionisti della salute, hanno improntato il mio mondo e la mia personalità.
Ripensandoci, non c’è da meravigliarsi che mi vergognassi così tanto di avere dolore persistente. Non c’è da stupirsi che mi sentissi in colpa. Perché è stato fatto davvero tutto il possibile per farmi sentire inadeguata, non tanto incapace di affrontare la situazione, quanto direttamente responsabile del suo mantenimento. Non dico sia stato fatto deliberatamente, con l’intento di nuocere, ma il risultato è questo.
Non ha senso negare la complessità del dolore, scaricando le colpe sul paziente, eppure è quello che è successo a me. Noi siamo persone con dolore persistente, non cattive persone, bugiarde, fragili, incapaci, non collaborative, irrecuperabili, condannate al dolore “per colpa nostra”; viviamo situazioni tremende, siamo costrette ad adeguarci ad uno “standard” con cui, francamente, nessun essere umano vorrebbe confrontarsi: lo so che lo dico spesso, che sono ripetitiva, è solo che voglio vi entri bene in testa. Vivere con il dolore cronico, non è normale.
Considerato quanto sia importante il linguaggio per chi soffre di dolore, a qualsiasi professionista della salute dovrebbe essere vietato usare termini inappropriati, quelli che finiscono con il farci sentire deboli, colpevoli (finirai su una sedia a rotelle, impara solo a conviverci, è il peggiore che abbia mai visto, ti resta solo Lourdes) o inefficaci (il dolore non passa perché non vuoi che passi, stai così per colpa tua), pazzi (la stai facendo troppo grossa, dagli esami non si vede niente). La raccolta può tranquillamente essere ampliata. Queste parole ci allontanano dalla guarigione, innanzitutto. In secondo luogo, sono disumane. E, nella nostra testa di persone con dolore persistente, consolidano un mondo fatto di inettitudine e sensi di colpa.
Un compito fondamentale nella psicologia del dolore è quello di aiutare le persone a imparare a riformulare il loro monologo interiore in modo che diventi più realistico e di supporto. Essere in grado di cogliere e riconoscere impulsi inutili o non realistici non è facile, ma questa abilità è alla base di molti adattamenti riusciti al dolore persistente. Questa intuizione costituisce la base della terapia cognitivo comportamentale (una forma di psicoterapia che mira a cambiare i comportamenti di pensiero inutili), che ha un ruolo importante nell’aiutare le persone a vivere con dolore persistente. Vivere con il dolore persistente, vivere bene con il dolore, è un obiettivo pienamente realizzabile, lo so per esperienza personale. Aggiungo che è pienamente realizzabile in un contesto in cui il paziente non sia regolarmente gambizzato dai professionisti della salute, cosa che capita ancora spesso.
Se il paziente deve essere guidato verso una maggiore consapevolezza, lo stesso deve accadere per chi si prende cura di lui: i professionisti della salute dovrebbero motivare le persone con dolore persistente, offrendo un linguaggio che deve essere scelto con cura al fine di prendersi più cura del paziente, non di remargli contro.
Quando un trattamento non funziona, è umano trovare qualcuno a cui dare la colpa. Eviterei di accusare il paziente, l’ho già detto. Eviterei anche di incolpare il clinico (anche se in questo caso, ammetto, mi ci vuole uno sforzo di misericordia, sono di parte). Del resto, accusandoci a vicenda, non abbiamo molto da guadagnare. Sicuramente un paziente motivato è un passo più vicino al successo, e un professionista della salute consapevole dei propri limiti saprà come motivare una persona, rispettarla, far passare le giuste informazioni, quando fermarsi e passare il testimone, o scegliere di informarsi.
Non credo che i professionisti della salute siano perfidi di natura. Credo che una volta assunto il fatto che “il vecchio modo di procedere” a cui siamo abituati sia deleterio, così come si cercano nuovi modi per i pazienti per aiutarli a riformulare i propri pensieri allo scopo di vivere bene con il dolore, debba essere dato maggior risalto all’importanza di “comunicare bene” il dolore da parte dei sanitari.
Se i pazienti desiderano essere aiutati, presumo che i sanitari vogliano aiutare, quindi se interpretassimo la relazione paziente/professionista della salute come dialettica e non come una partita fra squadre avversarie, potremmo ricavare del buono per entrambe le categorie.
C’è speranza per tutti.